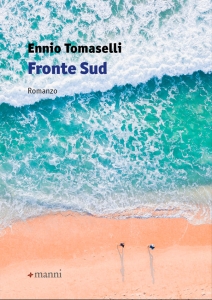Perché parlare ancora di “lui”?
“Uno come tanti è anche ciascuno di noi, chiamato a decidere se arrendersi o meno a ciò che viene dato per scontato, ma può essere frutto di arbitri, errori, ingiustizie. Una resistenza civile a cui, oggi come ieri, non ci si può sottrarre.”
Si concludeva così la scheda di presentazione del romanzo scritta questa primavera. Da allora sono trascorsi sei mesi e tanti eventi hanno connotato la storia e le nostre cronache personali. Hanno preso forma vari eventi legati al libro e sono emersi spunti di riflessione sempre nuovi: ciò anche grazie ai lettori e alla loro interazione, in varie forme, con le pagine del romanzo e l’autore.
Mi sono, tuttavia, interrogato sull’opportunità di dedicare al libro ulteriore spazio di riflessione comune.
In tempi come quelli che attraversiamo e abitiamo, che ci tengono continuamente in bilico come su una corda elastica ˗ una volta tirata verso il passato, con le sue immagini di guerre e orrori, e un’altra verso il presente-futuro, purtroppo così tristemente simile e minaccioso ˗, dedicare “troppo” tempo a un singolo libro potrebbe risolversi in una sorta di otium letterario.
Se, peraltro, oggi sono qui a scrivere, va da sé che ho deciso di proseguire questo cammino. Anzi con maggiore, se possibile, determinazione.
Il fulcro del libro, scrissi subito, è una storia di resistenza civile. Nella narrazione c’è un filo rosso che è la ricerca di verità, da parte del giovane Fabrizio, del padre Matteo e di tutti coloro che in qualche modo affiancano il loro percorso, nel passato e nel presente, di disvelamento della verità legata a tante situazioni e a tante scelte. Attraverso il topos letterario della ricerca del padre, si costruisce, come in un mosaico, un racconto di resistenze. Del figlio, che nonostante più ragioni di dubbio e scoramento continua la sua ricerca, e del padre, legato a un’antica scelta “forte” che lo ha vincolato a una serie di scelte conseguenti, anche se incomprensibili rispetto al “comune buon senso” e alle aspettative degli altri, fondate su stereotipi rispetto al ruolo di magistrato, visto in modo più iconico che realistico.
“Uno come tanti” è sicuramente un racconto di scelte: tutti possono imbattersi in realtà difficili o momenti critici, ma il bivio è pur sempre quello che porta a scegliere di andare avanti nonostante tutto o di rinunciare. I due protagonisti, il giovane e il vecchio, scelgono sino alla fine ˗ tra dubbi, ostacoli e disavventure ˗ di diventare bersagli di incomprensioni e anche di violenza, ma scelgono anche il campo per cui spendersi. Che non è quello dei ruoli costruiti a tavolino, non è quello dell’approvazione sociale, ma quello del rapporto con la verità delle loro storie e della Storia in cui restano coinvolti, ma che non subiscono passivamente. Essere uno come tanti, infatti, non significa per loro essere figurine sbiadite di un film per cui altri hanno scritto la sceneggiatura, ma piuttosto scegliere come essere se stessi: aperti alla realtà, al mondo e alle contraddizioni faticose di una coerenza ricercata tra dubbi e tentennamenti, ma poi perseguita fino alla fine.
In fondo la ricerca dei padri non è solo dal punto di vista letterario la testimonianza di un bisogno di verità sui nostri fondamenti. Anche con la riscoperta della storia di un periodo ancora “coperto” da censure, travisamenti, oblii più o meno interessati, può emergere il profondo legame possibile tra conoscenza e testimonianza. Testimonianza di come si possa essere sempre uno come tanti nel bene e nel male: senza protagonismi di redenzione, ma neanche accodandosi al coro silenzioso di rimpianti o assuefazioni tristi. E se è vero che i giovani faticano a trovare, se non nei libri o in figure esemplari del passato, modelli di coerenza vissuta nel divenire quotidiano della storia, è anche vero che gli anziani soffrono per non trovare intorno sensibilità verso la ricerca di fondamenti solidi che aiutino ad affrontare il nuovo senza tradimenti.
L’incontro tra queste due necessità è possibile solo attraverso un viaggio di ricerca reciproca, che presupponga alla base anche la necessità di reciproci adattamenti e cambiamenti. Può anche darsi che, poi, questi non conducano necessariamente ad un finale felice o “edificante” (nel romanzo come nella vita), ma si tratta comunque di un’esperienza ineludibile per non far fermare o far tornare indietro la storia.
Un rischio che non possiamo proprio permetterci.




 Magari, per avere un po’ di attenzione su questi temi, si metterebbe, chissà, anche a scrivere romanzi …
Magari, per avere un po’ di attenzione su questi temi, si metterebbe, chissà, anche a scrivere romanzi …


 Questa volta, però, ho visto anche ragazzi consapevoli: in una scuola la voglia di capire e di fare, da parte di studenti che si erano coinvolti nella lettura di Fronte Sud e si erano impegnati anche a commentarlo con gli strumenti a loro congeniali: video, suoni, immagini. Ragazzi capaci di stupirsi e ascoltare le voci di un passato che sembrerebbe non coinvolgerli ma che in qualche modo li ha ancora toccati. L’ho visto nei loro occhi attenti, nelle domande essenziali, nella voglia di capire. La memoria operosa è un lavoro molto faticoso, come ben sanno gli insegnanti che da anni si impegnano in questo tipo di percorsi.
Questa volta, però, ho visto anche ragazzi consapevoli: in una scuola la voglia di capire e di fare, da parte di studenti che si erano coinvolti nella lettura di Fronte Sud e si erano impegnati anche a commentarlo con gli strumenti a loro congeniali: video, suoni, immagini. Ragazzi capaci di stupirsi e ascoltare le voci di un passato che sembrerebbe non coinvolgerli ma che in qualche modo li ha ancora toccati. L’ho visto nei loro occhi attenti, nelle domande essenziali, nella voglia di capire. La memoria operosa è un lavoro molto faticoso, come ben sanno gli insegnanti che da anni si impegnano in questo tipo di percorsi.